Sachsenhausen
 Apertura: estate 1936
Apertura: estate 1936
Ubicazione: Germania, 35 km a nord di Berlino
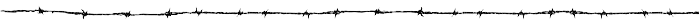
IL PRIMO LAGER, ORANIENBURG
A Oranienburg (ai bordi di Berlino) il primo lager venne costituito nel 1933, era uno dei tanti lager sorti dopo l’incendio del Reichstag con il pretesto della difesa dello stato da un presunto colpo di stato comunista. Questo primo lager venne chiuso nel 1934 come la quasi totalità dei campi delle prime ore, nel corso dell’istituzionalizzazione della “rivoluzione nazionale” nazista.
IL LAGER SACHSENHAUSEN
Nel 1936 viene costituito il campo di Sachsenhausen (dal nome della stazione ferroviaria di Sachsenhausen, la stazione ferroviaria immediatamente successiva a quella di Oranienburg). Fu il primo campo costruito apposta per essere un lager delle SS e avrebbe dovuto essere il campo modello del rilancio di tutto il sistema dei campi in un momento di svolta e di preparazione alla guerra.
Il primo nucleo di reclusi del campo fu costituito da avversari politici e oppositori del nazismo. Tra il 1937 e il 1938 il campo si riempì di vittime della politica di repressione “socialrazziale”: prima persone con precedenti penali, poi senzatetto ed altri cosiddetti “asociali”, Sinti e Roma, omosessuali e altri. Il 1938 è l’anno dell’ingresso in massa di circa 6000 cosiddetti “asociali” e successivamente di circa 6000 ebrei dopo il pogrom del 9 novembre.
Nel 1938 viene spostata a Oranienburg la IKL, l’ispettorato generale dei lager. Una volta al mese a Sachsenhausen si ritrovano tutti i comandanti dei Lager delle SS, anche il comandante di Auschwitz. Anche per questo a Sachsenhausen si sperimenta e si usa non solo il gas ma anche gli altri due metodi di uccisione di massa. Il campo di Sachsenhausen diventa un campo decisivo per la formazione di molti comandanti di altri campi, per esempio Rudolf Höß, futuro comandante di Auschwitz.
Sachsenhausen con la sua posizione ai bordi della capitale nazista, è anche un luogo privilegiato di visite prevalentemente di alleati, come Guido Landra, autore del “Manifesto per la Difesa della Razza” del 1938, che lascia un protocollo impressionante sulla sua visita nel campo.
All’inizio della guerra il campo costruito per 8000 persone ha circa 30 ettari e già 10.000 reclusi. Nel corso della guerra il campo il numero dei reclusi (e gli omicidi) crescono a dismisura, alla fine della guerra il campo arriverà a 380 ettari e circa 24.000 reclusi nel campo principale, oltre ad altri 50.000 in almeno 80 campi secondari. Delle almeno 200.000 persone passate per Sachsenhausen si stima un numero di morti tra 40 e 60.000 persone, il libro dei morti identificati del campo comprende attualmente (2025) circa 22.000 persone.
Dopo l’inizio della guerra, il 1° settembre 1939, il sovraffollamento diventa sempre più massiccio, soprattutto per l’arrivo di polacchi e altri abitanti di territori orientali occupati. Nel gennaio 1940 ha luogo il primo eccidio di massa, compiuto prolungando l’appello ed esponendo per ore al gelo centinaia di reclusi, probabilmente ordinato personalmente da Rudolf Höß, comandante dell’area del campo dove alloggiavano i reclusi. Nel 1941 con l’aggressione all’Unione Sovietica vengono portati nel campo fino a 13.000 prigionieri di guerra sovietici, 10.000 vengono assassinati in due mesi nell’impianto di sparo alla nuca dalle SS. Alla fine del 1942 vengono trasferiti ad Auschwitz gli ebrei ancora presenti nel campo, nel contesto dell’espulsione degli ebrei dal Reich e del tentativo della loro uccisione di massa.
Nella fase iniziale il lavoro dei reclusi viene sfruttato per la costruzione del campo e per collaborazioni con il comune e con le industrie private, come la pista per testare le scarpe. Dal 1938 in poi le SS si costruiscono un proprio impero economico, per esempio producendo materiali di costruzione per i grandi progetti di Albert Speer. Il 1942 è il momento di una svolta finalizzata a uno sfruttamento più conseguente della forza lavoro dei reclusi per lo sforzo bellico. Vengono introdotte facilitazioni per una minoranza di reclusi e contemporaneamente viene proseguita l’operazione T4 per uccidere con il veleno i malati considerati non più rigenerabili. Contemporaneamente aumenta il numero di campi esterni legati a fabbriche dell’industria bellica in cui lavorano sia reclusi del campo che prigionieri di guerra e lavoratori stranieri civili anche volontari. Viene aperta una “Officina di falsari” dove si producono dollari e sterline false per pagare gli agenti segreti.
A partire dal 1939 il campo cresce a dismisura, ci arrivano sempre più stranieri, sia dai territori dell´ Europa occupata che dalla Germania stessa. Si tratta di oppositori politici o comunque persone che non rispettano le regole poste dalle forze di occupazione ma anche di stranieri che sono lavoratori forzati in Germania, e diventano vittime della disciplina draconiana e dell’ossessione di evitare “la vergogna della razza”, cioè il contatto con “ariane”. Più della metà degli almeno 200.000 reclusi passati per Sachsenhausen sono non tedeschi.
Dal 1944 iniziano ad arrivare di nuovo a Sachsenhausen ebrei, sia da Auschwitz che dall’Ungheria. Nel 1945 la situazione diventa sempre più drammatica, il sovraffollamento e la violenza delle SS aumenta sempre di più. Il 21 aprile 1945 33.000 reclusi abbandonano il campo scortati dalle SS in una marcia a piedi verso nord. 3000 uomini e donne incapaci di muoversi vengono lasciati nel Lager. Dopo più di 10 giorni, nelle vicinanze di Schwerin, a circa 180 Km da Oranienburg, i reclusi superstiti si accorgono che le SS se ne sono andate e incontrano i russi e gli americani. Il 23 aprile il campo principale viene liberato da truppe polacche e russe che combattono insieme nell’Armata Rossa.
Già nel 1945 le strutture abitative del campo vengono prese in mano dai sovietici, che istituiscono prima un campo di filtrazione politica per i prigionieri di guerra sovietici liberati e poi un campo di denazificazione (come gli altri alleati nella rispettiva zona di liberazione). Il campo speciale sovietico viene chiuso nel 1950. Per circa 10 anni l’area del campo diventa una grande caserma della Nuova Armata Popolare della RDT. Nel 1961 viene istituito il primo Memoriale, circondato dalla caserma. Da questo memoriale, dopo una radicale ristrutturazione dopo il 1989, nasce il memoriale attuale, che comprende solo 5% dell’area complessiva del Lager originario.
ITALIANI A SACHSENHAUSEN
A Sachsenhausen arrivano tra 530 e 713 persone fondamentalmente dal territorio italiano o controllato da italiani fino all’8 settembre del 1943. Almeno 62 persone sono però italiani dalla Francia, dal Lussemburgo e dal Belgio, tra loro Sante Garibaldi, nipote di Giuseppe Garibaldi. La maggior parte degli italiani arriva dopo l´8 settembre del 1943. 145 sono militari catturati in massa nel settembre del 1943, che poi verranno chiamati IMI. Oltre 100 sono gli ebrei, che arrivano alla fine del 1944 dopo lo sgombero di Auschwitz. 34 sono antifascisti, partigiani, operai in sciopero e rastrellati. Tutti arrivano da altri campi, nessuno arriva direttamente dall’Italia. Per altri 78 Sachsenhausen è il primo campo di arrivo, sono lavoratori civili o militari diventati tali che vengono puniti, tutti arrestati su territorio tedesco. Almeno 84 sono italiani morti a Sachsenhausen, nel campo principale o in campi secondari. Non ci sono trasporti diretti dall’Italia.
Ci sono due arrivi relativamente numerosi di italiani, due gruppi ognuno di circa 60 persone, che arrivano nell’ottobre e nel dicembre del 1943. La maggior parte degli italiani è costituita da individui isolati dispersi nelle grandi masse dei reclusi di altre nazionalità. Solo un piccolo gruppo sembra rimanere unito dall’arrivo nel 1943 in una baracca come anche nel corso delle marce della morte del marzo del 1945.
TESTIMONIANZE DI ITALIANI A SACHSENHAUSEN (una scelta)
Antonio Temporini, Mattia Alberto Ansaldi, Luigi Isola, Luigi Calosso e Rubino Romeo Salmoni.
Claudio Cassetti, guida a Sachsenhausen e ricercatore
Per saperne di più:
Memoriale e Museo di Sachsenhausen
Claudio Cassetti, Iacopo Buonaguidi e Francesco Bertolucci, Gli italiani a Sachsenhausen. La deportazione nel Lager della capitale del Terzo Reich, Panozzo Editore, 2022

